“Ben oltre le idee di giusto e sbagliato c’è un campo.
Ti aspetterò laggiù”.
J. Rumi
Faremo un viaggio insieme, un viaggio di scoperta nell’angolo più buio della nostra mente.
E per intraprendere un viaggio del genere bisogna viaggiare con poco bagaglio, non possiamo essere appesantiti da opinioni, pregiudizi e conclusioni, tutto quel vecchio ciarpame che abbiamo messo insieme nel corso della nostra storia.
Iniziate dimenticando tutto quello che sapete su voi stessi, dimenticando tutto quello che avete pensato di voi; cominceremo come se non sapessimo niente di noi stessi, cercando di arrivare alle radici della nostra paura più grande.
Ogni viaggio necessita di una storia e secondo L. Wittgenstein, filoso e logico austriaco (1889 – 1951) le storie vissute sono episodi d’azione condivise, cioè esse rinviano sempre alla presenza di un altro, e quindi di un contesto relazionale che le storie raccontate non rendono immediatamente interpretabile, nonostante sembra esserci un significato evidente alla nostra portata.
Ciò significa che nessun individuo viaggia mai da solo, come vorrebbe la distinzione naturalistica tra soggetto e oggetto, bensì è abitato dalla relazione in cui è vissuto, quindi si riferisce sempre ad episodi di azioni condivise con l’altro.
Sulla porta della parte più buia della nostra mente troviamo un’etichetta linguistica abusata ma sconosciuta, logora ma utilizzata in maniera superficiale, da tutti rifiutata ma iper-usata: il giudizio.
L’etimologia della parola giudicare è da ricondurre al latino judĭcare, derivazione di judex = giudice. Judex deriva dall’unione di ius + decs (dicere) cioè colui che dice, che si pronuncia sul diritto. In senso più ampio, giudicare significa valutare, stimare, esprimere un’opinione.
Il giudizio è infatti uno dei ponti più potenti e distruttivi della relazione tra le persone: gli aggettivi caratterologici giudicanti, le parole che utilizziamo per racchiudere l’esperienza dell’altro in relazione con noi, secondo Bateson, definiscono le caratteristiche fondamentali di una relazione.
Nel definire una parte della relazione, gli aggettivi caratterologici determinano necessariamente anche l’altra e questo è l’aspetto fondamentale e generativo di questo lavoro, il suo costrutto centrale: essere libera/o implica che esista anche una/o schiavo/a; “giocare sporco” implica la percezione di un qualche tipo di pulizia.
Ad esempio, pensate a qualcuno con cui faticate a comunicare o una situazione che non comporta una interazione costruttiva.
Ora immaginate di essere in un grande teatro.
Guardate il modo di comportarsi di questa persona sul palcoscenico, il suo modo di muoversi, di usare la voce e trovate una parola che ne descriva il comportamento: potremmo utilizzare termini dal vocabolario caratterologico, ad esempio egocentrica, aggressiva, narcisista.
Ora fate un respiro profondo e sul palcoscenico vedrete voi stessi mentre interagite con quella persona: siete uno spettatore terzo, un osservatore neutrale.
Notate il vostro comportamento sul palcoscenico: quale parola utilizzereste per voi stessi in movimento? Probabilmente se l’altro è narcisista voi sarete dipendenti o timidi.
Ora possiamo cominciare a vedere il nostro contributo alla danza reciproca nella definizione del sé, una danza basata sulla ricerca di posizioni discorsive consensuali: cerchiamo nel giudizio quello spazio tempo verbale che ci consente di mantenere una relazione stabile con l’altro o con l’idea che abbiamo di noi stessi.
Il giudizio assolve alla funzione di ritrovare il controllo riferendoci a canoni socialmente accettabili e ritornando dentro l’alveo di quella divisione naturalistica soggetto – oggetto così tanto tranquillizzante, funziona come un meccanismo di omeostasi ma contiene anche un elemento di minaccia.
Siamo vicini alla comprensione della natura più profonda di questa paura della paura; abbiamo però la necessità di fare un passo indietro per comprendere quello che abbiamo davanti.
Dobbiamo salire su una nave spettrale, la nave dei folli, la stultifera navis, creazione letteraria ispirata al ciclo degli Argonauti, navi il cui equipaggio di eroi immaginari, di modelli etici, o di tipi sociali s’imbarca per un grande viaggio simbolico: il grande mito dell’esclusione degli alienati e della loro derisione che il filosofo M. Focault ha così brillantemente descritto nella sua storia della follia.
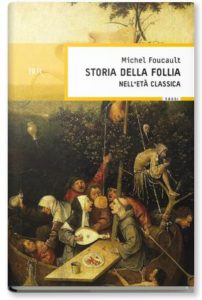 E’ qui che la grande paura si palesa: ciò che ci spaventa realmente è che il giudizio rappresenta un tentativo di azione sulla relazione, una azione che mira alla esclusione.
E’ qui che la grande paura si palesa: ciò che ci spaventa realmente è che il giudizio rappresenta un tentativo di azione sulla relazione, una azione che mira alla esclusione.
Il tema del giudizio diventa così inestricabilmente collegato a quello della esclusione, siamo spaventati dalla possibilità che gli altri possano osservarci e indicarci come alieni, estranei, con un chiaro effetto di allontanamento.
“Il piacere di condannare. […] Il piacere di esprimere una sentenza negativa è sempre inconfondibile. È un piacere duro e crudele, che non si lascia sviare da nulla. La sentenza è solo una sentenza quando viene pronunciata con una sorta di temibile sicurezza. Essa ignora indulgenza e precauzione. È presto trovata; ed è perfettamente coerente con la sua natura proprio quando scaturisce senza ponderazione. La passione che essa tradisce si collega alla sua rapidità. Le sentenze incondizionate e rapide fanno sì che il piacere si dipinga sul volto del sentenziante. […] Ci si arroga in tal modo il potere di giudice. Ma solo apparentemente il giudice sta nel mezzo, sul confine che separa il bene dal male. In ogni caso, infatti, egli si annovera tra i buoni. La legittimazione del suo ufficio si fonda soprattutto sul fatto che egli appartiene inalterabilmente al regno del bene, come se vi fosse nato. Egli sentenzia in continuazione. La sua sentenza è vincolante. Ci sono soggetti ben determinati sui quali è chiamato a giudicare; la sua vasta conoscenza del bene e del male deriva da una lunga esperienza. Ma anche coloro che non sono giudici, che nessuno ha incaricato di giudicare, che nessuna persona di buon senso incaricherebbe di giudicare, si arrogano continuamente il diritto di pronunciar sentenze su ogni argomento, senza alcuna cognizione di causa. Quelli che si astengono dal sentenziare poiché se ne vergognerebbero, si possono contare sulle dita. La malattia del condannare è una delle più diffuse tra gli uomini: in pratica, tutti ne sono colpiti.” (pag.1340 – 1431).
Di conseguenza, quello che ci spaventa del giudizio, più che il suo contenuto, è la sua natura fortemente pragmatica, di azione sulla relazione: “A questo proposito vorremmo che fosse chiaro fin da ora che usiamo i termini comunicazione e comportamento praticamente come sinonimi: perché i dati della pragmatica non sono soltanto le parole, le loro configurazioni e i loro significati (che sono i dati della sintassi e della semantica), ma anche i fatti verbali concomitanti come pure il linguaggio del corpo” (Watlawick P., pag.13).
Pensiamo, ad esempio, al valore e al potere della diagnosi in psichiatria e psicoterapia.
Una diagnosi rappresenta un’etichetta posta da un osservatore con l’obiettivo di oggettivare l’esperienza relazionale avuta, esprime un profondo bisogno di sicurezza, poiché questa operazione è un modo per non osservare, per sfuggire all’ansia dell’intersoggettività.
Quale è allora la via di uscita di questa malattia che colpisce tutti gli uomini?
Carl Rogers sosteneva che la tendenza a giudicare gli altri è la più grande barriera alla comunicazione e alla comprensione, ma è dalle parole di Stanisław Jerzy Lec (1909 – 1966), scrittore, poeta e aforista polacco che possiamo trarre ispirazione per questo piccolo lavoro sul giudizio: Ci saranno sempre degli esquimesi pronti a dettare le norme su come devono comportarsi gli abitanti del Congo durante la calura.
Mutuando il titolo di un recente libro di Guido Catalano, ogni volta che giudichi qualcuno risorge un nazista.
Dott. Andrea Stramaccioni
Bibliografia
- Canetti E., (1990) Massa e potere, trad. it. di F. Jesi, in Id., Opere, a cura di G. Cusatelli, Bompiani, Milano, vol. I;
- Catalano G., (2017) Ogni volta che mi baci muore un nazista, Rizzoli Editore, Milano;
- Foucault M., (2011) Storia della follia nell’età classica, RCA libri s.p.a., Milano;
- Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.D., (1971) Pragmatica della comunicazione umana, Casa Editrice Astrolabio Ubaldini Editore, Roma;
Sitografia

